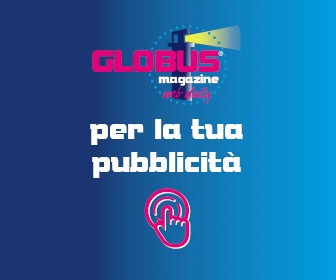Rappresentazione gradita dal numeroso pubblico da sold-out accorso al teatro catanese per il cartellone attuale delle opere liriche.

“La folle giornata overo le nozze di Figaro“, l’opera che ha allietato in primo turno il 25 febbraio il Teatro Bellini di Catania, regia di Michele Mirabella, direzione di orchestra di Beatrice Venezi, con numeroso concorso di pubblico, è stata data per la prima volta al Burgtheater di Vienna, con la direzione dell’autore Wolfgang Amadeus Mozart e il libretto di Lorenzo Da Ponte, il primo maggio 1786. Non è una data a caso: in quel giorno ricorreva il decennale della fondazione della confraternita detta degli “Illuminati di Baviera” ad opera di un prima oscuro professore universitario di Ingolstadt, tale Adamo Weishaupt, il quale vòlle riprendere la tradizione secentesca delle società segrete per innalzare e tramare politicamentre (la musica allora, era anche politica) per la instaurazione di un “governo mondiale“. Si insinuò egli quindi nella settecentesca, modernamente intendendo, Società dei Liberi Muratori e ne carpì “i misteri, mentre i massoni non sapevano i suoi“, è stato scritto. Si sa che sia Mozart che l’ex ebreo Emanuele Conegliano, convertito al cristianesimo e battezzato quattordicenne dal Vescovo Lorenzo Da Ponte (di cui assunse nome e cognome: oggi sarebbe sospettato di cose poco chiare, del resto il librettista mistifica nelle sue reticenti memorie) erano adepti della Massoneria. Anzi la composizione dell’opera di cui trattiamo, s’innesta nel più fecondo periodo della convinta, come ogni storiografo sa, adesione ideale del salisburghese alla società iniziatica. E se su ciò non vi sono dubbi, ve ne sono sulla sua affiliazione agli Illuminati. Verò è che su Mozart e il periodo come la morte, i misteri e le leggende fioccano: è anche vero che la rete della compagine la quale pochi anni dopo doveva portare al processo in Roma al Conte di Cagliostro (che non era l’impostore Giuseppe Balsamo, come finse di credere persino Goethe, altro iniziato agli Illuminati, nome in codice Abaris) nello stesso 1789 che si profilava come la cesura rivoluzionaria per eccellenza (il 2001 di tre secoli fa) era talmente fitta, giungendo persino nella nostra Catania (ove il Weishaupt invia prima il danese Federico Mùnter ad affiliare Ignazio V Principe di Biscari, Venerabile della Loggia massonica etnea -di stampo inglese- poi lo stesso Goethe, ma Ignazio moriva proprio in quel 1786 delle Nozze figariane) da annoverare Giovanni Simone Mayr ed Herder, come i Fratelli massoni del nostro Autore: al cui funerale era presente Antonio Salieri, massone pure lui (“Armonia per un tempio della notte” è una sua composizione specifica per ritualità iniziatica) però molto più prudente e diplomatico dello scatenato salisburghese e del suo sodale Da Ponte: quest’ultimo infatti emigrò in America agli abori della tempesta rivoluzionaria.
Come nel breve ma utile prologo alla serata, illustrato ai presenti dalla responsabile della comunicazione dell’Ente, la giornalista Caterina Andò e dall’attento musicologo e docente Giuseppe Montemagno, le polemiche della rappresentazione francese di Beaumarchais portarono i due autori a purgare, ma solo di facciata, il testo originale che sostanzialmente inneggia alla nascente piccola borghesia nata dal popolo da tempo oppresso. Era un rischio troppo grande ma Mozart, negli amori nelle avventure nella vita quotidiana, fu un temerario e la data del primo maggio (non casualmente poi divenuta, auspice il barbuto Carlo Marx che di esoterismo non era neppure lui digiuno, la festa dei lavoratori) lo dimostra. Ne pagò le conseguenze col Requiem e la morte troppo presto giunta, come il nostro Bellini? Non lo sapremo mai, mai si ritrovò il suo corpo, come quello degli eroi e semidei, “gente famosa” scrive la Bibbia in Genesi.

Ma l’opera data al Bellini dunque? Dalla scenografia classica e conformità nei costumi, scelta apprezzabile della regia (del resto il Mirabella, che molti rammentano come conduttore televisivo, ben fa a mantenersi nel solco della tradizione) alla buona e precisa direzione di orchestra, si dipanò nelle tre ore et ultra di rappresentazione, in un teatro pieno e fu gradita nel suo complesso, come il pubblico si compiacque di manifestare più volte applaudendo.
Specificatamente – come sempre salvo eccezioni, non scaliamo le “vette” delle “piccionaje” un tempo frequentate, stazionando nella platea de’ gentiluomini- apprezzammo il ruolo di Cristin Arsenova, giovane soprano nel ruolo di Susanna, la quale nella impostazione mozartiana è la vera protagonista dell’opera: se ella non ha ancora, me è agli inizi, un perfezionamento vocale ampio e deve “crescere” per quello che può nella estensione vocale, merita lode anche per la quantificazione scenica, frutto di impegno. Così apprezzammo la palermitana Desirè Rancatore nel ruolo della Contessa di Almaviva, una Rosina maritata dalla convincente maturità: il ruolo le si addice e le sonorità non scarseggiarono.
Teniamo a sottolineare la bravura del basso Luciano Leoni, che notàmmo subito nell’aria di Don Bartolo “La vendetta è un piacer serbato ai saggi“: infatti egli è stato allievo di Magda Olivero. Apprezzabile entro la consuetudine, il Cherubino en travestì del soprano leggero Albàne Carrere, che abbiamo sentito al Bellini anche in altre occasioni; nella norma il Figaro del basso Gabriele Sagona, così il Conte di Almaviva interpretato da Luca Bruno nonché il don Basilio di Saverio Pugliese e il cameo di Barbarina, di Federica Foresta. Rileviamo che nel secondo cast a svolgere il ruolo di Cherubino, tra i più celebri della lirica mondiale per la celebre “canzone” “Voi che sapete, cosa è amor“, sono due deliziose voci del panorama etneo, il mezzosoprano Sonia Fortunato e il mezzosoprano Sabrina Messina. Acconciature e trucco a cura di Alfredo Danese, del quale in questa occasione piace ricordare il papà Gaetano recentemente scomparso, che per lunghi anni è stato responsabile del settore acconciatura del teatro. Di grande spessore le titolarità umane del teatro, tecniche e scenografiche.

Belle e articolate altresì, secondo partitura, le presenze dell’ottimo Coro del Bellini, come di consueto istruito da Luigi Petrozziello. Attenta l’orchestra del teatro, con qualche nuova inserzione. I cinque minuti degli applausi finali non mancarono di manifestare la accettazione del pubblico catanese per codesto ritorno mozartiano nella città che lo stesso 25 febbraio, ma del 1844, vide nascere Mario Rapisardi, Poeta e libero pensatore, alfiere della lirica del novo evo nazionale; così il 25 febbrajo ma nella luminosa Napoli nasceva nel 1873 ovvero cento e cinquanta anni fa, Enrico Caruso il quale portò nel mondo la lirica italiana cum magna laude.
Alla serata al Bellini, tra i presenti, si notarono il giovane e promettente direttore di orchestra Sirio Scacchetti, il neo consigliere del CSM professore Felice Giuffrè, la pittrice Ausilia Miceli, il direttore artistico del teatro Maestro Fabrizio Carminati, l’impresario Marco Impallomeni e diversa mondanità; sempre impeccabile la coppia Lisa Majorana e Giovanni Cultrera di Montesano, Sovrintendente del teatro. Presente la Real Casa d’Epiro Delegazione di Sicilia e Malta e la Legione Garibaldina Comando per la Sicilia.
“Le nozze di Figaro” non hanno solo il pregio di aver consacrato, col Don Giovanni e Così fan tutte della trilogia notissima, il genio mozartiano: sono altresì, specie se si fa caso alle parole di elogio e disprezzo per le donne e i matrimoni e le beffe che di questo costume ancestrale ma divenuto grottesco nel secolo dei Lumi, se ne fanno i due autori, chiaramente definendo per bocca di Figaro “scimuniti” i mariti e furbe nell’ingannarli le mogli (come fa Rosina da Contessa, come fa Susanna da destinata a Figaro): è una satira assolutamente corrosiva, che beffeggia chi indossa abiti bianchi laddove si sa che tutto possono significare tranne purezza e illibatezza; è patogenesi di un formale inganno erto a consuetudine, ma Mozart altro non poteva fare che descriverlo così, squadernando alla bigotta e parruccona -di facciata: in realtà libertina quant’altre mai lo saranno, neanche nel XXI secolo! – società settecentesca, le burle gli inganni i tradimenti la lutulenta fangosità degli amanti negli armadi, che sono storie delle vita di Wolfgang e di Lorenzo ma anche di moltissimi altri, ieri come oggi. E alla fine, insegnò il buon Machiavelli nelle pagine conclusive della Mandragola, tutti in Chiesa a pregare, mariti cornuti, amanti felici e amici consapevoli. Per questo cogliere l’oscuro e metterlo in scena gioiosamente, Mozart è un posseduto dal dàimon come lo erano gli ideatori del Circo romano che ammansivano i popoli col sangue delle belve e dei gladiatori: l’orgasmo di Cherubino con le più o meno velate allusioni, o la narrativa di Figaro del “Non più andrai farfallone amoroso” (mentre sa che egli lo sarà sempre: l’aria celebre è stata ripresa dal maestro dell’erotismo Tinto Brass in un suo film di successo, “Miranda” anno 1985 ispirato alla locandiera goldoniana) è una apoteosi del piacere sfrenato e senza limiti, in un secolo che in privato ne abusava, in pubblico lo gestiva. Ciò non poteva essere accettato in modo diretto e produsse il Buonaparte e la normalizzazione del secolo decimonono. Ad onta dell’avvertimento di Figaro (“Ah che il fidarsi a donna è ognor follia!”) le cantanti liriche del secondo Ottocento e primo Novecento, dalla bella Otero a Lina Cavalieri, furono la rovina degli uomini: certo una sola si suicidò per amore, Liliana Castagnola, il cruccio maggiore del Principe Antonio De Curtis, in arte Totò: “un tuo bacio è tutto” e poi la morte. Vecchie storie di pianoforti di anelli e di baci rubati nei giardini pubblici un tempo ritrovo riservato di coppie celebri come la Contessa di Sordevolo col Cavaliere Giovanni Verga, scrittore del vero, amante senza limiti; o le passioni del “caro orco” Giosue Carducci che ultra cinquantenne e barbuto, impazzì per la fresca poco più che ventenne Annie Vivanti. Il mondo è sempre lo stesso, “in contenti e in allegria solo Amor può terminar”, secondo i versi finali dell’opera mozartiana.
Oggi che l’allegria, ungarettianamente, è o sembra svanita nella società ‘moderna’, appare un ossimoro. Ma noi che ricordiamo le primavere, la auspichiamo ancora coi versi – più bello se letti a notte in riva al mare, come facevano gli eleganti – del Prevèrt: “Ils sont ailleurs bien plus loin que la nuit Bien plus haut que le jour Dans l’éblouissante clarté de leur premier amour“.