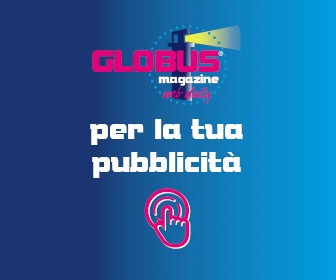Fabrizio Catalano, nipote di Leonardo Sciascia, di recente ha tradotto dal francese il poema di Charles Van Lerberghe “La canzone di Eva”.

Regista internazionale, scrittore erudito premiato durante la prestigiosa manifestazione Biennale Internazionale Sicily Trinacria, dedica gran parte della sua vita all’arte.
Leggendo il titolo del libro, ogni lettore si chiederà che cosa è questo simbolismo che accentua il nostro vivere in una molteplicità di esser soggetti?
“Però cos’è, esattamente, questo Simbolismo? È un concetto così labile, diafano, da risultare addirittura inconsistente; ma è pure l’ultimo fenomeno culturale capace di spingere l’umanità – che dallo scoppio della Prima guerra mondiale ai giorni nostri sembra inesorabilmente avviata al disfacimento – oltre la brutalità dei sistemi patriarcali che hanno nella sopraffazione la loro fede. Si fa risalire la sua origine al sonetto Correspondances di Baudelaire, a una sorta di dichiarazione d’intenti di Jean Moréas, ad articoli di Émile Verhaeren o di Albert Aurier; ma le più autentiche manifestazioni dell’arte hanno sempre avuto, fin dal Neolitico, una dimensione magica e simbolica. Più che un movimento organizzato, il Simbolismo è stato uno scudo e un ricovero per donne e uomini insofferenti al positivismo, allora e adesso imperante, e alle conseguenze di un progresso sfrenatamente capitalista e rapace. Un gruppo di visionari che intuiva l’imminente decadenza e alimentava l’ostinata volontà, se non di contrastarla efficacemente, di rendere una testimonianza armoniosa, controcorrente, indocile”.
Concetti profondi e pieni di significati reconditi. Tante le spiegazioni che ogni lettore attento potrebbe dedurre ma, in realtà, che cosa significa Hibris?
“Hybris è un sostantivo greco sommariamente tradotto con arroganza o tracotanza, ma che indica in realtà l’atto, più o meno consapevole, dell’andar oltre i limiti imposti dagli dei. È il crimine di cui si macchierebbe Ulisse se s’imbevesse nella conoscenza delle sirene, sono le insussistenti offese di Marsia, colpevole di suonare superbamente, o di Icaro, che vorrebbe volare. È il peccato originale. La malia ardente di Lucifero. Il reato di chi si oppone al potere costituito. La Eva di Van Lerberghe varca per contro la soglia dell’hybris accettando la condizione mortale – o acquisendone coscienza – pur di accedere alla verità”.

Potresti accennare alla trama del famoso poema di Charles Van Lerberghe?
“Nel corso di questo poema iniziatico, che attinge alla filosofia naturalista, capovolge gli assunti biblici e disprezza gli ammaestramenti contenuti nel paradiso perduto di Milton, la prima donna – o ragazza, dato che l’autore a più riprese fa riferimento alla pubertà mesopotamica e alla perversa ingenuità adolescenziale come modello anche per il suo Pan lapidario e miracoloso – malinconicamente scruta la stella pallida da cui è disceso. A quel punto, è come se un nuovo Eden si spalancasse agli occhi capaci di curiosità e stupore: un lussureggiante regno che, se per Eva è gioioso preludio, per un’altra generazione di abitatori è crepuscolo. Ostili a Dio e agli angeli, sirene, fate, chimere, la stessa Venere e le sue ninfe considerano Eva come una di loro, vengono verso di lei dalla loro incipiente notte a mostrare ducia nella sua aurora. È quasi un passaggio di testimone. E, squarciando la cortina del divieto e ascoltando il canto ipnotico e savio delle sirene, Eva s’affrancherà da ogni sovrastruttura e radiosamente ritornerà alla Natura. Il serpente – infinita redenzione – e il giovane dio – che certi commentatori s’ostinano a definire angelo caduto o Satana, senza che Van Lerberghe impieghi mai questi termini – porgono alla degna prescelta la conoscenza e l’amore libero. Dio è morto; con le sue dita nivee, con le sue labbra e i suoi denti, strappando dal ramo la mela e mangiandola, priva d’odio, Eva lo ha ammazzato. O forse no: quel dio dei limiti e delle preclusioni non era che una proiezione: nulla sapeva che esisteva, niente sa che non c’è più.
Nessuna offesa a un’autorità superiore, nessuna punizione: Eva aveva ammirato, al di là della porta, l’altro lato della vita, con la sua luce immota e diaccia e i rami dei salici riversi sulla sabbia. Prima ancora che lo smeraldino serpente la tentasse, attraverso il panteistico insegnamento delle sirene, la ragazza aveva già intuito tutto. Ed è intrigante segnalare come, nel medesimo anno in cui il libro viene pubblicato, il 1904, mentre queste loquaci sirene infondono saggezza, quelle di Giovanni Pascoli, ostinatamente mute, conducono Ulisse, tornato da loro anch’egli ansioso di verità, alla morte: il che contribuisce a dimostrare come, benché inevitabilmente permeato dal clima di quell’epoca, Van Lerberghe tenda a dare d’ogni secolare e moderno mito un’interpretazione fulgidamente eversiva.
L’usurpatore s’eclissa, e le sollecitazioni sottilmente erotiche, di cui l’autore ha in precedenza disseminato la sua opera, divengono esplosioni insieme dionisiache ed apollinee. La riscoperta nudità non provoca imbarazzo, vergogna, tanto meno è peccato; piuttosto emozione, voluttuoso turbamento, orgasmo. L’Eden viene stravolto: Eva ama il giovane dio e s’unisce in danze sfrenate ad angeli dal sesso cangiante che appaiono come flautate, fiammeggianti, impetuose personificazioni di elementi naturali; col vino del suo sangue, in un delizioso sabba al chiaro di luna, attrae a sé la colomba bianca. Da oscure foreste gli uomini vengono ad adorarla, a prostrarsi dinnanzi a lei. In lei resuscita l’anima di Lilith, fino all’ingresso della grotta dove, forse, la sospirata verità sonnecchia. Un momentaneo nembo di oppressione e di malinconia plana su Eva, all’occaso della sua breve e meravigliosa parabola: anche se estremamente audace, lei si sente troppo piccola per affrontare l’ineluttabilità della morte. «À l’ivresse de comprendre» – chiosa il poeta Albert Mockel dopo la lettura del testo – «succède la tristesse de savoir». Lente anime solcano il cielo. La donna è ora spossata; avviluppandola nelle sue ali, Azraele le dischiude il definitivo segreto: non c’è nulla di più sublime che disciogliersi ancora nell’universo”.
Fabrizio Catalano è regista e drammaturgo negli ultimi tempi ha riscosso tanto successo di pubblico e di critica con spettacoli tratti da alcuni testi del suo famoso nonno Leonardo Sciascia. È stato per anni direttore artistico del Teatro Regina Margherita di Racalmuto. Ha realizzato documentari e cortometraggi ed ha tradotto dal francese molti noti testi. Lo potrete seguire anche sui social. – nasce fra i petali della rosa dell’universo e si rivolta contro quello che potrebbe essere stato il suo creatore, ma potrebbe anche non essere mai esistito.
Eva apre gli occhi in un giardino incantato e accanto a lei non v’è Adamo; sola di fronte ai fremiti del pianeta, riceve da Dio l’incarico di dare un nome agli abitanti della Terra e l’ordine di fermarsi all’esteriore venustà delle cose, di non interrogarsi sul piacere. Nathalie Zabus ha con acutezza rimarcato che, in questa prima fase, l’atteggiamento di Eva rasenta la passività: ella spesso sogna o fantastica; e solo nella seconda sezione del poema più intensamente prende a guardare e a vedere. Cosa scatena in lei questa metamorfosi?
Forse proprio la parola verità che improvvidamente la voce – quella voce che solo lei ode – si lascia scappare. E poi le seducenti ciarle d’un uccello del paradiso che le promette il paese dell’eterno domani e che lei si stanca d’inseguire. Quindi, lo scorgere quel giovane dio, che si rivelerà essere l’Amore e che, appoggiato all’albero proibito, nella posizione del fauno di Prassitele – Van Lerberghe userà questa statua come modello anche per il suo Pan lapidario e miracoloso – malinconicamente scruta la stella pallida da cui è disceso.
A quel punto, è come se un nuovo Eden si spalancasse agli occhi capaci di curiosità e stupore: un lussureggiante regno che, se per Eva è gioioso preludio, per un’altra generazione di abitatori è crepuscolo. Ostili a Dio e agli angeli, sirene, fate, chimere, la stessa Venere e le sue ninfe considerano Eva come una di loro, vengono verso di lei dalla loro incipiente notte a mostrare ducia nella sua aurora. È quasi un passaggio di testimone. E, squarciando la cortina del divieto e ascoltando il canto ipnotico e savio delle sirene, Eva s’affrancherà da ogni sovrastruttura e radiosamente ritornerà alla Natura. Il serpente – infinita redenzione – e il giovane dio – che certi commentatori s’ostinano a definire angelo caduto o Satana, senza che Van Lerberghe impieghi mai questi termini – porgono alla degna prescelta la conoscenza e l’amore libero.
Dio è morto; con le sue dita nivee, con le sue labbra e i suoi denti, strappando dal ramo la mela e mangiandola, priva d’odio, Eva lo ha ammazzato. O forse no: quel dio dei limiti e delle preclusioni non era che una proiezione: nulla sapeva che esisteva, niente sa che non c’è più.
Nessuna offesa a un’autorità superiore, nessuna punizione: Eva aveva ammirato, al di là della porta, l’altro lato della vita, con la sua luce immota e diaccia e i rami dei salici riversi sulla sabbia. Prima ancora che lo smeraldino serpente la tentasse, attraverso il panteistico insegnamento delle sirene, la ragazza aveva già intuito tutto. Ed è intrigante segnalare come, nel medesimo anno in cui il libro viene pubblicato, il 1904, mentre queste loquaci sirene infondono saggezza, quelle di Giovanni Pascoli, ostinatamente mute, conducono Ulisse, tornato da loro anch’egli ansioso di verità, alla morte: il che contribuisce a dimostrare come, benché inevitabilmente permeato dal clima di quell’epoca, Van Lerberghe tenda a dare d’ogni secolare e moderno mito un’interpretazione fulgidamente eversiva. L’usurpatore s’eclissa, e le sollecitazioni sottilmente erotiche, di cui l’autore ha in precedenza disseminato la sua opera, divengono esplosioni insieme dionisiache ed apollinee. La riscoperta nudità non provoca imbarazzo, vergogna, tanto meno è peccato; piuttosto emozione, voluttuoso turbamento, orgasmo. L’Eden viene stravolto: Eva ama il giovane dio e s’unisce in danze sfrenate ad angeli dal sesso cangiante che appaiono come flautate, fiammeggianti, impetuose personificazioni di elementi naturali; col vino del suo sangue, in un delizioso sabba al chiaro di luna, attrae a sé la colomba bianca. Da oscure foreste gli uomini vengono ad adorarla, a prostrarsi dinnanzi a lei. In lei resuscita l’anima di Lilith, fino all’ingresso della grotta dove, forse, la sospirata verità sonnecchia.
Un momentaneo nembo di oppressione e di malinconia plana su Eva, all’occaso della sua breve e meravigliosa parabola: anche se estremamente audace, lei si sente troppo piccola per affrontare l’ineluttabilità della morte. «À l’ivresse de comprendre» – chiosa il poeta Albert Mockel dopo la lettura deltesto – «succède la tristesse de savoir». Lente anime solcano il cielo. La donna è ora spossata; avviluppandola nelle sue ali, Azraele le dischiude il definitivo segreto: non c’è nulla di più sublime che disciogliersi ancora nell’universo”.
Fabrizio Catalano è regista e drammaturgo negli ultimi tempi ha riscosso tanto successo di pubblico e di critica con spettacoli tratti da alcuni testi del suo famoso nonno Leonardo Sciascia. È stato per anni direttore artistico del Teatro Regina Margherita di Racalmuto. Ha realizzato documentari e cortometraggi ed ha tradotto dal francese molti noti testi. Lo potrete seguire anche sui social.