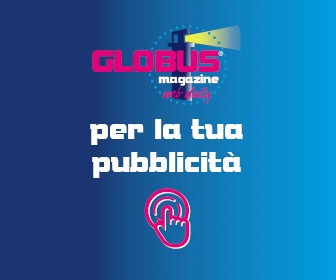La messa di Requiem scritta da Pacini in onore di Bellini e due pagine di musica sacra del Cigno estremamente apprezzate dal pubblico, direttore d’orchestra il Maestro Epifanio Comis.

In occasione delle festività belliniane settembrine -come noi appelliamo la rassegna ormai al termine definita con termini anglomani- organizzate dal Teatro Bellini in collaborazione con l‘Istituto musicale omonimo e le altre istituzioni pubbliche catanesi, si tenne sabato primo ottobre, nel tempio santuario di San Francesco d’Assisi all’Immacolata, celebre perché ospita la tomba della Regina di Sicilia Eleonora d’Angiò, sede del noto culto mariano nonché costruito sulle rovine del tempio di Minerva (ognun sa o deduce la continuità religiosa degli antichi riti, dall’evo greco romano a quello cristiano) il concerto di musica sacra dedicato ai due sommi musicisti catanesi Vincenzo Bellini e Giovanni Pacini: l’uno, il “Cigno” per eccellenza a cui è legata la stessa immagine della città, l’altro, nato per caso a Catania ma celebre dipoi per alcune opere nel suo tempo seppure mai quanto il grande giovane biondo, come egli stesso in età matura riconobbe. Non si può neanche far cenno a confronti tra l’autore della “Saffo”, pure osannata al San Carlo nel loro secolo, il decimonono, e il creatore di Norma e Puritani: ma è bello che la città celebri questi prestigiosi figli -non basta aver ad entrambi dedicato i due pubblici giardini- con l’intento, magari caduco ma necessario, di educare quella parte sensibile del popolo a codeste sacre laiche memorie, tanto coltivate fino a un quarantennio fa con estrema passione. Si, poiché la Catania della fine degli anni Settanta e della prima metà degli anni Ottanta -nota per fatti di cronaca nera dai detrattori spacciati come periodo oscuro- sempre più, al confronto con l’oggi, emerge come una grande città attenta e cultrice della storia patria, quanto non lo è quella attuale, riferendoci in particolare alla istituzione che più di ogni altra dovrebbe promuoverla, ovvero il Comune. Sono edite nel 1981 “Le mie memorie artistiche” di Giovanni Pacini, con prefazione di Gianandrea Gavazzeni e finanziate dal Comune di Catania: ivi l’allora Sindaco Salvatore Coco precisava come l’amministrazione era impegnata nella riscoperta di Pacini come musicista e come didatta e fondatore delle scuole musicali comunali. Si tenga presente che nel 1980-81 neanche esisteva quello che ora s’appella “Assessorato alla Cultura” ma.. era tutto demandato, con grande umiltà ed evidente competenza, alla Pubblica Istruzione. E’ utile ricordarlo sia ai criticoni sia a chi ha poca memoria e crede che tutto è opera dell’oggi, ma noi che -seppur fanciulli all’epoca- abbiamo ricordi chiari di quel tempo, crediamo giusto rammentarlo. Nostalgicamente, se proprio si deve fare un raffronto, a paragone dei giorni attuali tanto disfatti almeno per quanto concerne l’amministrazione comunale.
Nella serata del primo ottobre, con inizio (chissà perché, forse per la giornata del sabato e invogliare i turisti d’ogni nazione che infatti gremirono la navata centrale della chiesa) alle 22, il Coro del teatro Bellini e l‘Orchestra dell’Istituto Musicale “Bellini” (rinforzata invero da parecchi elementi dell’Orchestra del teatro) diretti rispettivamente da Luigi Petrozziello e dal professore Epifanio Comis, che è anche il Direttore dell’Istituto nonché valente pianista, si eseguirono di Bellini due pagine giovanili del periodo catanese, durante il quale egli seguiva le indicazioni del padre Rosario e del nonno Vincenzo Tobia, che avevano l’appalto della musica sacra nelle più importanti chiese e monasteri di Catania e provincia. Da qui, abbiamo ascoltato il “Tecum principium” per orchestra con la voce solista del giovane soprano giapponese Kasumi Hiyane (non prevista nel programma) la quale, già reduce dal successo della Butterfly data al museo diocesano per la Camerata Polifonica Siciliana, lo ha replicato pochi giorni fa al castello Ursino a cura dell’Istituto musicale di cui è tra le migliori allieve della classe di canto, in versione ridotta. Un piccolo gradevole “cameo”.
 Il “salve Regina” in la minore di Bellini venne eseguito dal coro, orchestra e solisti il soprano Micaela Sara D’Alessandro, il mezzosoprano Giuseppina Piunti, il tenore Max Jota e il baritono Salvatore Grigoli. Le medesime quattro voci interpretarono le parti a loro dedicate nella Messa funebre di Requiem di Giovanni Pacini in memoria di Vincenzo Bellini, scritta nel 1865 allorché in tutta Europa, coinvolto lo stesso Pacini, si dissertava del ritorno in patria delle spoglie del Cigno, sepolto a Parigi dopo la prematura dipartita. Una partitura, quella del Requiem paciniano, a cui il “maestro delle cabalette” (come egli veniva appellato negli anni trenta dell’Ottocento) lavorò nella maturità in maniera nuova ma attingendo al fasto delle pagine rossiniane (Gioacchino era suo amico) e del grande repertorio francese e tedesco, da Lully a Haydn a lui ben noti. Da antico “mestierante” della musica, il Pacini ormai sessantenne (e già coi baffi che furono il biglietto da visita di quel secolo, fino al novecento della grande guerra: quasi certamente anche Bellini li avrebbe avuti se fosse vissuto quanto il Pacini) si slanciò nel fasto scenografico degli ottoni, della maestosità del coro e degli accenni sinfonici, per scrivere delle pagine che volano dal sommesso religioso al grande anelito di maestà che egli voleva incidere come ricordo, del concittadino che “mi ha superato” come anche Donizetti, lo ammise serenamente nelle memorie, ma di cui conservò un affettuoso ricordo. Poteva ormai permetterselo: finiti gli anni delle rivalità (più da parte di Bellini che di Pacini, il quale seppure aveva sui vent’anni scritto l’opera “la sacerdotessa d’Irminsul” sapeva bene la caratura di Bellini e non tentava di competere: diversamente Vincenzo era giovane irruento, spesso infastidito dalle scritture ottenute da Pacini nei varii teatri) lo stemperarsi delle passioni lo portava a narrare col filtro ma serenamente. Non eravi solo rivalità artistica: i fatti personali e le donne nobili, le quali dall’Ottocento fino alla seconda metà del Novecento furtono determinanti per la vera cultura italiana ed europea ed anche per la politica (un esempio fu a Catania la Marchesa Giulia Romeo delle Torrazze della quale ci si narrava qualche giorno fa: Dama di corte di Sua Maestà la Regina Elena di Savoja, era nella nostra città fino agli anni Settanta il riferimento dei monarchici, essendo col marito amicissimo del Re Soldato, testimoni dei tempi belli e delle ore buje di quel giorni), avevano pesato notevolmente per allontanare i due. E mentre Bellini diventava intimo della signora Giuditta Cantù in Turina, moglie di un degno ma non celebre industriale lombardo, il nostro Giovanni era il favorito addirittura della Principessa Paolina Bonaparte Borghese, ovvero non solo la sorella dell’Imperatore ma una delle donne più splendide e potenti d’Europa, la Bellezza per antonomasia scolpita dal Canova. Dovette sposarsi per “coprire” la liason ma la moglie mori (non prima di avergli dato i primi tre figli, la primogenita Paolina, come la donna del cuore… similmente il principe De Curtis, fece con la prima e unica figlia). Poi s’ebbe l’affare con la Contessa Samoyloff, influentissima nel mondo teatrale. Bellini solo verso la fine della sua vita e a Parigi, potè e per pochissimo tempo, entrare nel salotto politico e letterario della Principessa di Belgioioso, ma il suo giorno stava rapidamente spegnendosi, mentre quelli meno luminosi ma più sereni di Pacini, durarono fino a oltre la terza guerra di indipendenza. E’ una lettura che deve compiersi, per capire l’avventura umana di questi nostri grandi personaggi.
Il “salve Regina” in la minore di Bellini venne eseguito dal coro, orchestra e solisti il soprano Micaela Sara D’Alessandro, il mezzosoprano Giuseppina Piunti, il tenore Max Jota e il baritono Salvatore Grigoli. Le medesime quattro voci interpretarono le parti a loro dedicate nella Messa funebre di Requiem di Giovanni Pacini in memoria di Vincenzo Bellini, scritta nel 1865 allorché in tutta Europa, coinvolto lo stesso Pacini, si dissertava del ritorno in patria delle spoglie del Cigno, sepolto a Parigi dopo la prematura dipartita. Una partitura, quella del Requiem paciniano, a cui il “maestro delle cabalette” (come egli veniva appellato negli anni trenta dell’Ottocento) lavorò nella maturità in maniera nuova ma attingendo al fasto delle pagine rossiniane (Gioacchino era suo amico) e del grande repertorio francese e tedesco, da Lully a Haydn a lui ben noti. Da antico “mestierante” della musica, il Pacini ormai sessantenne (e già coi baffi che furono il biglietto da visita di quel secolo, fino al novecento della grande guerra: quasi certamente anche Bellini li avrebbe avuti se fosse vissuto quanto il Pacini) si slanciò nel fasto scenografico degli ottoni, della maestosità del coro e degli accenni sinfonici, per scrivere delle pagine che volano dal sommesso religioso al grande anelito di maestà che egli voleva incidere come ricordo, del concittadino che “mi ha superato” come anche Donizetti, lo ammise serenamente nelle memorie, ma di cui conservò un affettuoso ricordo. Poteva ormai permetterselo: finiti gli anni delle rivalità (più da parte di Bellini che di Pacini, il quale seppure aveva sui vent’anni scritto l’opera “la sacerdotessa d’Irminsul” sapeva bene la caratura di Bellini e non tentava di competere: diversamente Vincenzo era giovane irruento, spesso infastidito dalle scritture ottenute da Pacini nei varii teatri) lo stemperarsi delle passioni lo portava a narrare col filtro ma serenamente. Non eravi solo rivalità artistica: i fatti personali e le donne nobili, le quali dall’Ottocento fino alla seconda metà del Novecento furtono determinanti per la vera cultura italiana ed europea ed anche per la politica (un esempio fu a Catania la Marchesa Giulia Romeo delle Torrazze della quale ci si narrava qualche giorno fa: Dama di corte di Sua Maestà la Regina Elena di Savoja, era nella nostra città fino agli anni Settanta il riferimento dei monarchici, essendo col marito amicissimo del Re Soldato, testimoni dei tempi belli e delle ore buje di quel giorni), avevano pesato notevolmente per allontanare i due. E mentre Bellini diventava intimo della signora Giuditta Cantù in Turina, moglie di un degno ma non celebre industriale lombardo, il nostro Giovanni era il favorito addirittura della Principessa Paolina Bonaparte Borghese, ovvero non solo la sorella dell’Imperatore ma una delle donne più splendide e potenti d’Europa, la Bellezza per antonomasia scolpita dal Canova. Dovette sposarsi per “coprire” la liason ma la moglie mori (non prima di avergli dato i primi tre figli, la primogenita Paolina, come la donna del cuore… similmente il principe De Curtis, fece con la prima e unica figlia). Poi s’ebbe l’affare con la Contessa Samoyloff, influentissima nel mondo teatrale. Bellini solo verso la fine della sua vita e a Parigi, potè e per pochissimo tempo, entrare nel salotto politico e letterario della Principessa di Belgioioso, ma il suo giorno stava rapidamente spegnendosi, mentre quelli meno luminosi ma più sereni di Pacini, durarono fino a oltre la terza guerra di indipendenza. E’ una lettura che deve compiersi, per capire l’avventura umana di questi nostri grandi personaggi.
Il concerto ebbe un più che buono riscontro: il ritorno vocale del Coro sempre appassionato e ardito, anche se all’inizio vi era qualche perplessità, fu pastoso e dignitoso anche perché la navata permise la concentrazione delle onde; la direzione del Maestro Comis, attenta e seria -importante per un catanese dirigere Pacini-; il pubblico tra turisti e melomani, gradì molto le esecuzioni e gli oltre cinque minuti di applausi, lo testimoniarono. Tra i presenti, il celebre soprano paternese Daniela Schillaci accompagnata dalla figlia Giulia (la ascolteremo nuovamente in Traviata in programma nel cartellone del Bellini), il direttore artistico del teatro Bellini Maestro Fabrizio Maria Carminati, il Sovrintendente dello stesso, Maestro Giovanni Cultrera di Montesano, il soprano e regista Orie Tanaka, il giovane Maestro Sirio Scacchetti (che meritamente ha curato la revisione critica e la trascrizione, con Andrea Passanisi, della Messa di Requiem paciniana) e altri; immancabile la Delegazione di Sicilia e Malta della Real Casa d’Epiro e la Legione Garibaldina comando per la Sicilia.

Probabilmente, Pacini, nel vergare le note del Requiem per Bellini, era già conscio che i suoi giorni erano vicini allo spegnersi : morirà due anni dopo. Dilaniati dalle donne Bellini e Pacini fra amore e morte, le due colonne del tempio della vita di codesti sommi Artisti, legate al vertice dell’arco da un nodo azzurro: quello dell’armonia stellata e tetractica. Con i versi di Jorge Luis Borges: “E’ l’amore. Dovrò nascondermi o fuggire. Crescono le mura delle sue carceri, come in un incubo atroce. La bella maschera è cambiata, ma come sempre è l’unica. A cosa serviranno i miei talismani: l’esercizio delle lettere, la vaga erudizione, le gallerie della biblioteca, le cose comuni, le abitudini… c’è un angolo di strada dove non posso passare, il nome di una donna mi denuncia…. è l’amore con le sue mitologie, con le sue piccole magie inutili”. Perché, sempre Borges (da 17 haiku, il settimo): “Da quel giorno / non ho toccato i pezzi / sulla scacchiera”. E tutto si ferma: all’uscita dal tempio, il palazzo Gravina Cruyllas dove Vincenzo nacque: pochi metri avanti all’angolo di via Garibaldi con via Abate Ferrara, la piazzetta di Sant’Antonio nella cui allora locanda (una lapide lo ricorda) nacque Pacini, febbraio 1796. I colori i suoni si confondono, nel silenzio della notte. E’ l’amore, è forse la morte: “o bianca impassibile Dea, non forse la morte, sei tu?” (Mario Rapisardi). La commedia continua, finché ancora vi è luce.